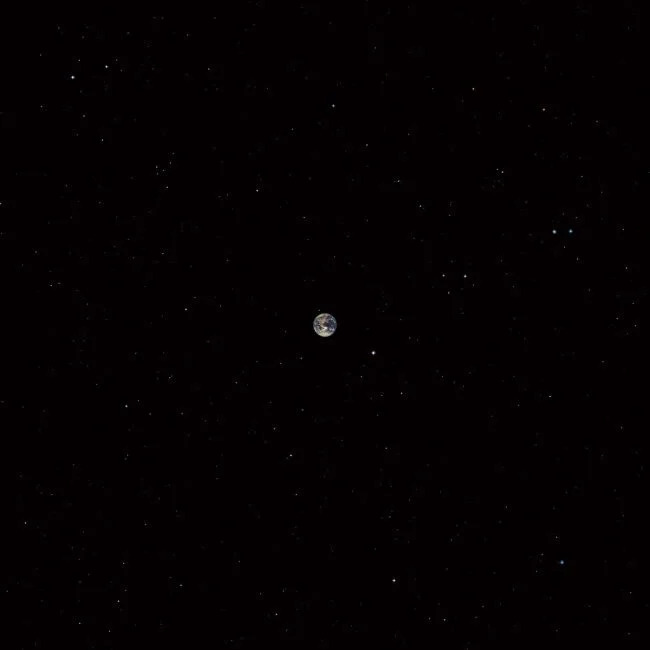Hope, speranza. Da due anni a questa parte la parola forse più adoperata dalla popolazione mondiale. La pandemia ha regolato le vite di noi tutti, trasformandole, anzi forse meglio dire impacchettandole, a distanza di sicurezza: mascherine, guanti, due metri tra un viso e l’altro e via discorrendo.
Speranza, la stessa che il veterano delle sei corde, Marc Ribot ha voluto cristallizzare in un disco, l’ultimo del trio Ceramic Dog, che è un discorso così intimo che vale la pena spifferarlo al mondo intero. Partiamo per gradi: musicalmente parlando c’è tutto il ventaglio dei “cani di ceramica”; melodie spezzate, contorni tesi, estrema libertà di espressione e quella sana inafferrabilità che da sempre ha tratteggiato il bagaglio sonico della band statunitense. Del loro precedente Yru Still Here è rimasto il sentore di asprezza e contaminazione, così come il desiderio di spiazzare l’ascoltatore in ogni modo. E allora ecco la ricetta perfetta dei Ceramic Dog anche in questo Hope: funk, noise rock, jazz, psichedelica e improvvisazione, una commistione tenuta insieme dalla bravura dei singoli elementi, ossia il batterista Ches Smith, il polistrumentista Shahzad Ismaily e il già citato Ribot. A proposito del chitarrista e frontman della band, occorre rimarcare la sua innata cura all’apparato testuale. Le liriche, infatti, non sono mai buttate lì a caso per colorare la melodia, nient’affatto, sono lì per pungere e smuovere le coscienze di chi ascolta con sensata e mordace satira sociale e politica.
Dopo tredici anni di musica, lo stato di forma del trio capitanato dal sempreverde Ribot è invidiabile e impeccabile: è davvero dura pretendere di più da queste tredici sospensioni di sonorità multiformi e, permettetemi un aggettivo “pandemico”, contagiose.
Bentornati Ceramic Dog e bentornata speranza!