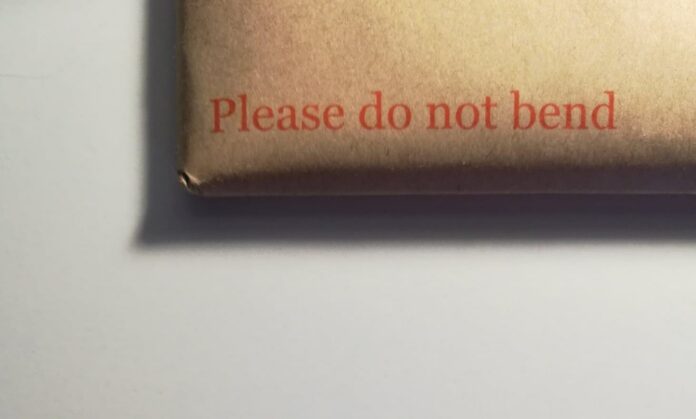Brevi note sulle recenti pubblicazioni di Claudio Rocchetti e Carlo Lei.
«Già s’intravede l’argomento generale: l’insaziabile ricerca di un’anima attraverso i delicati riflessi che essa ha lasciato nelle altre»: il Borges di Finzioni pare appropriato a dar conto -non recensire, per carità- di due minuscole pubblicazioni che a distanza di pochi giorni l’una dall’altra ci sono state recapitate nella buchetta delle lettere.
Entrambe avvolte in carta da pacco marrone, entrambe con gli indirizzi del destinatario e del mittente scritti a mano: pratiche antiche, come lo è, forse, il gesto di scrivere (di sé), stampare (in autonomia o quasi) e diffondere (personalmente e capillarmente) il proprio lavoro.
Please do not bend è stampigliato in rosso nell’angolo in basso a sinistra su una delle due buste: con questa attitudine riceviamo queste intime, finanche spudorate autobiografie.
Tormentata, visionaria, a procedere per slanci e strappi quella di Claudio Rocchetti, morbida, paterna, accogliente quella di Carlo Lei.
Non piegare, maneggiare con cura.
La polvere e le cose e Febbre alta -questi i titoli- sono (auto)biografie intese in senso etimologico, cioè scritture di vite (bios) e, dunque, di corpi: tema dominante, sia come oggetto che come soggetto di linguaggio.
Lingua-corpo, che ricorda i precipizi di Burroughs in un caso e certi guizzi di Caproni o Rebora nell’altro, a sondare inedite possibilità espressive e soprattutto percettive: i delicati riflessi di cui ci parla Borges, appunto.
Sublimarsi, frantumarsi, reificarsi, travestirsi: sono diversi gli stratagemmi che l’io adotta, nei racconti di Rocchetti e nelle poesie di Lei.
Testi che in realtà sono qualcosa di meno (o di più, o comunque di altro) rispetto alla forma-racconto e alla forma-poesia per come ci sono state insegnate.
Sono parole, questo si può forse azzardare, alla ricerca di un tu. Persona, cosa, luogo o condizione che sia: alterità.
Già Montale parlava di poesia che andava verso la prosa, nel Novecento. Bisognerebbe forse aggiungere, ora: verso un franare progressivo della dicibilità.
È ciò che più colpisce, in queste due piccole pubblicazioni: l’insaziabile tensione verso altri ii (per dirla con Sanguineti) con cui (non) incontrarsi.
Verso corpi in cui (non) imbattersi.
Perché quando uno dice «Io» – appunto – che cosa ti pensi che pensa, in fondo? – Nemmeno lo sa, quello che pensa, veramente. – E invece, dice queste cose qui, proprio, prima di tutto – perché dice i piedi dice tante dita – e poi dice la fronte, le cosce, l’ombelico – non so – dice le ginocchia, le ascelle – no?
Edoardo Sanguineti, Storie naturali, 1971.
MICHELE PASCARELLA
–