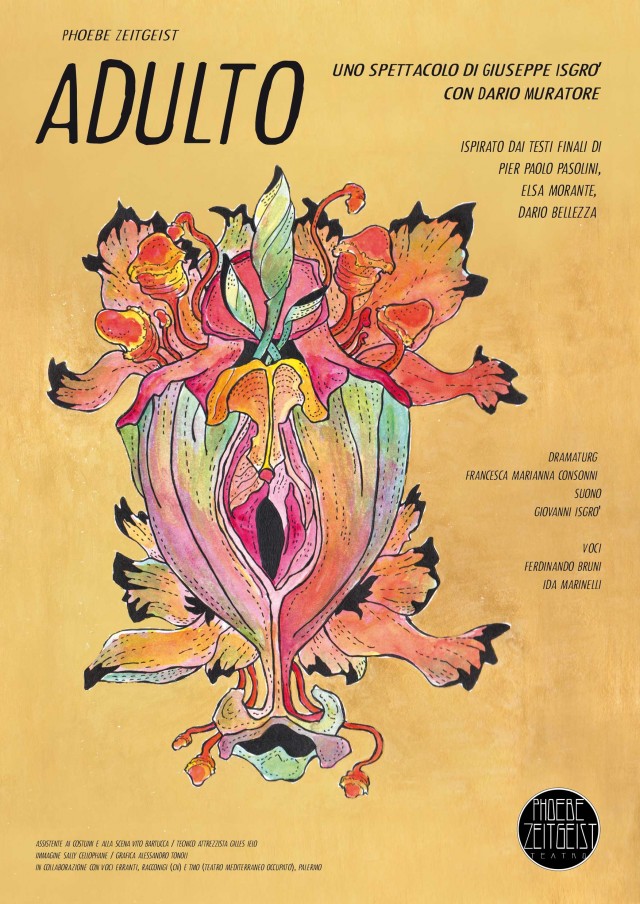.
Arrivo al Valtorto e tutto è ino.
Un atriino, una scalettina, una lucettina. Verde.
Poi si sale al primo piano. Si mette il giubbottino nell’attaccapanni. Si entra nella salettina.
File di sedie oblique. A terra un tappeto quadrato. Verde.
Ai lati alcuni neon. Un piccolo pianoforte giocattolo, bianco. Cavalluccio, secchielli, mangianastri con microfonino. Tutto ino. In attesa dell’inizio le persone parlano. Pianino.
.
.
Arriva l’attore, Dario Muratore, in boxer.
Inizia a raccontare con enfasi, tutte le e apèrte da attore che fa l’attore. Questo non aiuta.
E non aiuta nemmeno il testo scelto, pezzi da Il pratone della Casilina, l’Appunto 55 da Petrolio di Pasolini. Per chi non lo conosce: periferia romana, Carlo in mezzo a un campo consuma rapporti orali con (detto altrimenti: fa servizietti a) una ventina di ragazzi. Descrizioni dettagliate delle operazioni.
Non aiuta il testo, o meglio: non aiuta l’autore, San Pier Paolo Pasolini da Bologna. Meraviglia di intellettuale e artista, non devo certo dirlo io, ma davvero non se ne può più del santino che da quarant’anni i teatranti ne fanno. Lui che in vita con il teatro aveva sempre litigato: indifferenza reciproca, se non astio mal dissimulato, tra la società teatrale e lui. Fiaschi del suo Pilade, fischi sul suo Orgia.
Poi viene ammazzato.
E molti teatranti di questo nostro curioso Paese iniziano a omaggiarlo, a metterlo in scena, e sull’altare. Prima i testi teatrali, poi anche gli altri: Sandro Lombardi, Virgilio Sieni, i Motus, Fabrizio Gifuni, Nanni Garella, Mario Martone, Armando Punzo, il Teatro delle Ariette, Danio Manfredini, Ascanio Celestini. E ovviamente Pippo Delbono. E tanti, tanti, tanti altri.
.
.
Comunque.
Dario Muratore si veste: camicia chiara, pantaloni corti blu, bretelle bordò, giacca.
Il testo, già decisamente passionale, è detto con toni enfatici e azioni iper-energiche: salti e slanci a tratti finanche autolesionistici. Fa un po’ l’effetto del versare un’intera confezione di panna montata sopra una crostata alla ciliegia ricoperta di cioccolatini. L’attore ansima e si butta a terra, geme e urla.
Sofferenza e pathos.
Un eccesso di espressione che svuota il racconto.
Un surplus di presenza che rende il corpo, narrato e presentato, unicamente corpo-cosa, res extensa.
Un gran rumore che schiaccia ogni malinconia di quel testo, ogni sua delicatezza e, quel che è peggio, ogni fantasma.
Un attore che fa l’attore. E le parole, tutte, sottolineate. E “oscèno” detto con la e apèrta.
Invaso da questo eccesso penso che la maestria sarebbe farlo sparire, il corpo, in un racconto che parla di pelle e sperma, di prepuzi e sudore. Farlo scomparire sarebbe un colpo da maestro, sbattercelo in faccia lo è un po’ meno.
,
.
Poi, nella seconda parte, Adulto cambia registro.
Testi forse di Elsa Morante e Dario Bellezza, ma non ne sono sicuro.
Voce di gola e urli.
Temi: la sofferenza del distacco dalla madre, il non riconoscersi nel proprio corpo (uomo/donna), la madre che accetta il proprio figlio sempre e comunque, il figlio che vorrebbe tornare nella madre e piange.
E giù per una scivolosissima china di stampo psicanalitico.
Dario Muratore inizia a staccare con i denti i fili elettrici dell’alimentazione dei neon a terra.
La giustapposizione delle due parti pare proponga una lettura (a mio avviso discutibile, in ogni caso un po’ vetusta): rapporto irrisolto con la madre? Ecco che mi diventi omosessuale. Ma magari no, mi sbaglio, il significato è un altro, sono io che non ho capito.
Mentre lo spettacolo va avanti mi viene da pensare a Kurt Schwitters, Günter Brus e Lev Tolstoj. E non è un buon segno. Comunque.
Mi dico che il dispositivo di Adulto funzioni come una Merzbau.
Ricopio: «Dal 1923 Kurt Schwitters accumula detriti su detriti attorno alla cosiddetta colonna Merz, assemblaggio costituito da oggetti di scarto, secondo il principio schwittersiano di procedere a un riscatto costante degli elementi considerati infami e schifosi, da destinare a qualche discarica. Cattedrale delle miserie erotiche: il titolo integrale della Merzbau è esattamente questo. Di titolo e di fatto, poiché la colonna iniziale si espande dentro l’abitazione di Schwitters, ad Hannover, occupando prima un piano intero con quintali di oggetti che l’artista deposita a strati creando meandri, pertugi, spazi del tutto irregolari, poi sfondando soffitto e pavimento, su e giù, a invadere altri appartamenti del palazzo. Se Marcel Duchamp sceglie i suoi investimenti estetici nell’ambito del “già fatto”, Schwitters compie la stessa operazione di prelievo, ma in lui agisce la spinta a cercare tra un ammasso di oggetti, dove in qualche modo il tempo cronologico e atmosferico trasmette alle cianfrusaglie l’alone del “già sfatto”. Emanazione freudiana: ammasso del rimosso».
Günter Brus. Il simpatico esponente dell’Azionismo Viennese nel 1968, nella performance Arte e rivoluzione, beve la propria urina e si spalma addosso le proprie feci. Si masturba davanti al pubblico, urlando a squarciagola l’inno nazionale austriaco. È passato quasi mezzo secolo.
,

.
Infine Tolstoj: «E prese a parlare solo di sé, senza notare che agli altri l’argomento non interessava tanto quanto a lui. Un uomo non è mai tanto egoista quanto nel momento di un turbamento emotivo. Gli sembra che al mondo, in quel momento, non esista nulla di più bello e di più interessante di se stesso».
Tre giorni dopo mi metto a scrivere queste righe e trovo la rassegna stampa diffusa dalla Compagnia.
Ora, non siamo ingenui: è chiaro che ogni artista mette in mostra i passaggi più lusinghieri di ciò che è stato scritto, ma quello che leggo davvero mi colpisce, non tanto perché qualcuno può aver apprezzato qualcosa che a me ha lasciato perplesso (non è una questione di mi piace/non mi piace più, per quella c’è Facebook). Qui pare davvero che altri abbiano visto qualcosa di diverso da ciò che ho visto io. Come dire: non discutiamo se questa pizza è buona o cattiva, ma se questo cibo che abbiamo davanti è una pizza o un gelato.
Faccio due esempi, piccoli e concreti, per capirci. Salvatore Margotta su Teatro.it vede «essenzialità» e «un lavoro di cesellatura e pulizia formale» là dove io ho ricevuto una strabordante accumulazione di segni. Vincenzo Sardelli su KLP racconta di «una gestualità icastica mai troppo esibita», mentre io ho patito esattamente l’opposto.
.
.
Ora: il punto ovviamente non è stabilire chi abbia ragione: sono sguardi di critici che stimo, pubblicati in testate autorevoli. E non devo certo dirlo io.
Il punto forse è, ancora una volta, accorgersi che il modo in cui guardiamo le cose cambia le cose.
Le fa, propriamente, esistere.
Ecco dunque, da Adulto di Phoebe Zeitgeist porto a casa un promemoria (e di questo ringrazio): ogni tanto, invece di guardare e basta, devo ricordarmi di «guardarmi guardare».
MICHELE PASCARELLA
Visto il 3 novembre 2015 a Fornace Zarattini, Ravenna – info: onnivoro.org, pzteatro.org