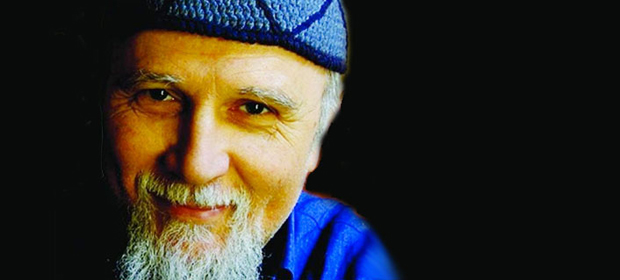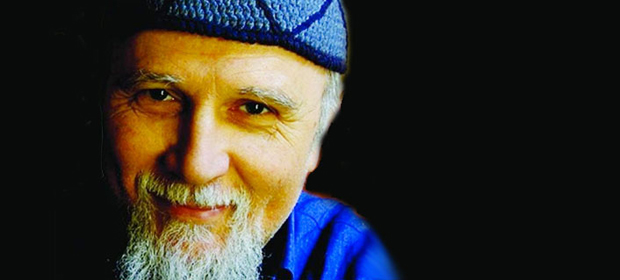Venti anni fa la sua musica e la sua voce accompagnavano le coreografie che, diligente e sudato, eseguivo alla Scuola dell’Attore del Teatro Due Mondi di Faenza. In scena l’ho visto cinque o sei volte, in spettacoli diversissimi fra loro. Ho letto un paio di suoi libri, tra i quali uno -geniale- da cui prendo in prestito il titolo per questo articolo. Ora mi trovo a intervistarlo bevendo caffè d’orzo, come fossimo vecchi amici.
Qualche anno fa si autodefinì “un folk singer che fa teatro”. Direbbe la stessa cosa, oggi?
Sì: il folk singer, oltre a proporre le canzoni del repertorio tradizionale, le racconta. Spiega aneddoti, riferisce contesti, è sempre anche un entertainer. In qualche misura è ciò che io ancora sono.
È corretto “leggere” tutta la sua arte, anche quando scrive libri o lavora in teatro, in senso cinematografico?
Indubbiamente. Per esempio quando ho allestito lo spettacolo che più mi ha fatto conoscere, Oylem Goylem, i caratteri che volevo dare ai musicisti guardavano a una precisa iconografia filmica: Il vagabondo chapliniano e i lavori dei fratelli Marx. Pochi ricordano che il primo film sonoro (The Jazz Singer, con Al Jolson, 1927, NdR) racconta la vicenda di un figlio di un cantore, un rabbino, che lascia il mondo della fede per intraprendere la carriera di cantante di varietà. Al Jolson narrava la sua vera storia: lui in origine era un cantore di sinagoga.
A proposito di sinagoghe: ci può raccontare cosa avviene durante le celebrazioni in questo “teatro totale”?
Non posso riferire di ciò che accade nelle sinagoghe in generale, ma solo in quelle originarie del centro-est Europa (nelle quali, comunque, sono entrato da outsider, da ebreo di discendenza ispanica, ancorché nato in un Paese slavo). Durante le celebrazioni succedono contemporaneamente le cose più disparate: la lite di due congreganti che discutono sull’ordine delle preghiere mentre si sta svolgendo la preghiera, il rabbino che fa omelie intrise di aneddoti e sberleffi, il cantore che leva il suo canto a fianco di qualcuno che chiacchiera e fa battute, le donne che si collocano nell’area della sinagoga riservata agli uomini scatenando polemiche fra progressisti e conservatori… È una ininterrotta pulsazione di scenette, da cui all’improvviso si leva il momento tragico della memoria. Sono presenti una quantità di gesti rituali: passi avanti e indietro, segni precisi che accompagnano la cantillazione della Bibbia, … Nella cerimonia gli officianti e il pubblico sono intercambiabili: a differenza del mondo cristiano, in cui il rito deve essere celebrato da un sacerdote, in quello ebraico un uomo pio, consapevole di ciò che deve fare, va bene. Nelle preghiere, salmodiate o cantate, le risposte non sono uniformi: ci si accavalla, come in una composizione musicale, in una sorta di eterofonia sfasata. È un insieme di movimento, ritmo, canto, umorismo, chiacchiera, scontro, polemica: è teatro.
Dove si può collocare l’origine dell’umorismo ebraico?
Nella nascita del primo ebreo: non Abramo, idolatra politeista convertito al monoteismo, ma suo figlio Isacco. Tre arcangeli travestiti da viandanti passarono dalla tenda di Abramo e gli annunciarono che lui (centenario) e sua moglie Sara (sterile da sempre e novantenne) avrebbero avuto un figlio. All’annuncio, Abramo si buttò a terra ridendo. Anche Sara rise. Il Padre Eterno impose loro di chiamare il figlio Isacco, nome che in ebraico significa letteralmente “riderà”: lo scenario umoristico inaugura l’utopia ebraica del monoteismo, è la risata che mostra che un miracolo è possibile, anche se si è molto vecchi. E che il progetto che dà vita è sempre aperto. La risata ne sottolinea il carattere vivificante e salvifico.
È possibile che l’umorismo venga “utilizzato” dal pubblico per sfuggire al peso dei temi spesso drammatici dei Suoi spettacoli?
Non credo. L’umorismo ebraico non è mai auto consolatorio: il suo ruolo è far pensare, smascherando il pregiudizio e le idolatrie. Serve a mostrare al carnefice quanto è stupido e insensato ciò che fa. Ha la funzione di rilanciare, anche nelle circostanze più tragiche, la centralità della vita.
Il Suo teatro cosmopolita è un esempio concreto di come la lingua possa essere considerata un sistema di suoni, prima che un insieme di significati.
Anni fa ho messo in scena uno spettacolo in quattordici fra lingue e dialetti. Questo è nulla, se si pensa che il nostro paesaggio sonoro quotidiano è costituito da almeno ottantacinque idiomi: malgascio, bengalese, polacco, ucraino, … Le lingue sono prima di tutto musiche, sistemi sonori. Se ci si lascia andare al suono, secondo me prima o poi si accede anche al significato.
Questa convinzione informa anche il Suo lavoro sul canto?
Certamente. In questo ambito il mio guru è Marie Keyrouz, suora libanese che canta in arabo il canone cristiano. La sua voce è germinativa, è una sorgente: Suor Marie Keyrouz apre la bocca per farla uscire, ma non la produce. È la più grande lezione che io abbia ricevuto in vita mia. Mi interesso a ogni forma di canto: quello del muezzin e il fado, ad esempio. Ieri ero con la cantante sarda Elena Ledda. Le ho detto: «Vorrei averti sul comodino, accenderti la mattina. E lasciarmi andare».
Ha spesso definito il regista polacco Tadeusz Kantor «l’assoluto teatrale». Ritiene di avere “continuato” il suo lavoro?
Non mi azzardo a dire una cosa del genere. Per un suo spettacolo Kantor, il cui padre era ebreo, mi chiese un canto che esprimesse la tragedia del popolo ebraico da far eseguire a un’attrice che interpretava il personaggio della Strofinona: un’infima serva inginocchiata, trafficata dai viandanti per il loro piacere. I maestri del cassidismo ebraico dicono che tanto più una cosa sta in basso sulla terra, tanto più alta è la sua radice nel cielo: così gli feci ascoltare un canto che ha come testo l’atto di fede nella venuta del Messia. Kantor ne fu esaltato. Un giorno mi scrisse, in merito a una mia musicassetta che gli avevo regalato: «La tua voce mi dà la disperazione necessaria. E anche un po’ di speranza». Io non avrei fatto il teatro che faccio, se non avessi incontrato Tadeusz Kantor.
C’è qualcuno oggi che Lei riconosce come allievo, o comunque come continuatore di una strada che Lei ha aperto?
Enrico Fink è un giovane musicista, attore e cantante che considero molto vicino a me. Era una promessa dell’astrofisica, ma quando vide un mio spettacolo abbandonò quella scienza dicendosi: «Questo è ciò che io voglio fare».
Per concludere: progetti futuri?
Sto preparando assieme a Lucilla Galeazzi, forse la più importante interprete italiana odierna di canto tradizionale, uno spettacolo sulla Prima Guerra Mondiale: Doppio fronte – oratorio per la Grande Guerra. Inoltre sto allestendo con la grande Orchestra Toscanini un recital delle canzoni milanesi di Enzo Jannacci. Porterò Oylem Goylem in Argentina. E andrò a Vienna per organizzare alcune ricerche. Mi muovo in continuazione, perché se la morte mi vede tranquillo mi porta via, mentre se mi agito lei sa che dovrà far fatica a prendermi. E va a cercare qualcun altro.
MICHELE PASCARELLA
lunedì 16 giugno, ‘Doppio fronte – Oratorio per la grande guerra’, di e con Moni Ovadia e Lucilla Galeazzi, Ravenna, Teatro Alighieri, info: 0544 249244, ravennafestival.org